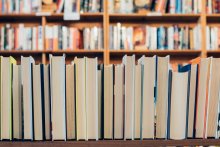In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, avvenuta il 25 aprile 1945, pubblichiamo un contributo di Antonio Maria Orecchia, professore di Storia contemporanea all’Università dell’Insubria, che pronuncerà domani l’orazione ufficiale nel corso delle commemorazioni a Varese.
---
1945-2025
NEL RICORDO SI SOPRAVVIVE
Di Antonio Maria Orecchia
Nel secolo dei nostri padri e dei nostri nonni – il “Secolo delle tenebre”, come lo ha definito Tzvetan Todorov – la libertà e la democrazia si affermarono non per gentile concessione, ma dopo scontri durissimi, guerre fratricide e milioni di morti.
Anche per questo allora oggi, 80 anni dopo, forse più che mai si sente il bisogno di una sincera pacificazione, per poter celebrare giornate come queste con spirito unitario. Perché queste giornate appartengono – o dovrebbero appartenere – a tutti gli italiani. A tutti, nessuno escluso.
Ora. Come disse Umberto Eco in una magistrale lezione alla Columbia University nel 1995, pacificazione e riconciliazione nazionale significano «compassione e rispetto per tutti coloro che hanno combattuto la loro guerra in buona fede».
Un traguardo emotivo certo non facile che – però – non significa dimenticare. Al contrario, “scordiamoci il passato” lascia buchi nella memoria e priva la democrazia delle sue categorie di giudizio.
Se dunque riconciliazione significa compassione e rispetto per chi ha combattuto in buona fede, si può anche ammettere – come sosteneva Eco – che Adolf Eichmann, il contabile dello sterminio, credesse veramente in quello che faceva, ma questo non significa che si possa dire “bene, torna e rifallo”. Anzi, l’unico modo per evitare che queste tragedie si ripetano è conoscere, capire e ricordare, perché come scriveva Benedetto Croce, «Qual è il carattere di un popolo? La sua storia, tutta la sua storia, nient’altro che la sua storia».
E, allora, si deve almeno partire dalle 19.42 dell’8 settembre 1943, quando l’EIAR, l’Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, annunciò un proclama del capo del governo, sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio: «Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare l’impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria […], ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower […]. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza».
Erano dunque le 19.42 dell’8 settembre del 1943 quando Pietro Badoglio, capo del governo da 45 giorni, annunciava agli italiani l’armistizio in questi termini a dir poco ambigui e infelici: cosa significava infatti reagire «ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza?». E infatti, certo non per caso, la popolazione rimase sbalordita, nella vana speranza che la guerra fosse finita.
L’Italia era in guerra da tre anni. Da quando, il 10 giugno 1940, Benito Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia aveva annunciato grandiosamente: «Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell’Occidente che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l’esistenza medesima del popolo italiano […]. La parola d’ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti […]. Vincere! E vinceremo».
Così aveva detto il Duce, ma tre anni dopo il bluff della guerra parallela, disastrosa su tutti i fronti, dalla Francia fino ai Balcani, all’Africa e fino all’Unione Sovietica, aveva distrutto il Paese e portato allo stremo i cittadini, se oltre alle centinaia di migliaia di morti, ai bombardamenti quotidiani e agli sfollamenti, il razionamento del cibo prevedeva un uovo a persona ogni 15 giorni, 80 grammi di carne e 60 di salumi alla settimana, 2 chili di pasta e 1,8 di riso al mese. Un livello di vita semplicemente insostenibile.
L’Italia era la prima potenza dell’Asse a capitolare. Era la più debole, ma era anche la culla del fascismo, e quindi la sua capitolazione aveva un forte significato politico, oltreché militare.
L’8 settembre fu dunque uno spartiacque, ma la guerra non finì e l’Italia sprofondò in una delle pagine più buie della sua storia. Il Re e Badoglio, temendo la vendetta tedesca, abbandonarono la capitale e scapparono a Brindisi; l’esercito, lasciato senza ordini, si sfaldò; i soldati fuggirono cercando di tornare a casa, le truppe nei territori d’occupazione furono abbandonate alla mercé del nemico.
L’immagine dell’8 settembre fu quella di una nazione allo sbando, dello sfascio delle istituzioni, di un popolo vinto, senza una guida, senza un esercito, senza idee e dignità.
Come è noto, alcuni storici – da Renzo De Felice a Ernesto Galli della Loggia – hanno parlato di «Morte della Patria» per dare il senso di quello che stava succedendo, della rinuncia morale della Nazione: «Tutto quanto le generazioni italiane avevano da un secolo in qua costruito politicamente, economicamente e moralmente, è distrutto irrimediabilmente» scrisse quella notte Benedetto Croce nei suoi Diari.
Comunque, adesso toccava all’Italia diventare il teatro di scontri tra eserciti, e tra eserciti e popolazione civile. Il Paese si trasformava in pochi giorni in un campo di battaglia: invaso a sud dagli alleati, a nord dai tedeschi. Con il Re e il governo fuggiaschi in Puglia, e a nord e al centro i plenipotenziari di Hitler a comandare il nuovo governo di Mussolini, a capo della sedicente Repubblica Sociale Italiana voluta dai nazisti e accettata da Mussolini stesso.
Una Repubblica, come ha scritto Claudio Pavone, che «Non avrebbe in realtà potuto durare un solo giorno senza il sostegno tedesco». Ma, soprattutto, una scelta – quella di costituire la Repubblica Sociale – che pure Renzo De Felice, il più noto biografo di Mussolini, ammise fosse all’origine della guerra civile perché aveva diviso profondamente gli italiani e scavato solchi di odio tra loro.
Da qui, io credo, si deve partire per capire il significato profondo del 25 aprile.
Questo era infatti l’inevitabile finale di vent’anni di dittatura, di una politica razzista e antisemita, dell’asservimento dell’Italia alla Germania nazista. E di una guerra sbagliata che aveva diviso gli italiani.
Corrado Alvaro lo descrisse in modo crudo nell’assai noto volume «L’Italia rinunzia» sin dal 1945: «Gran parte d’Italia si augurò la disfatta sin dal primo giorno della guerra […]. Gli italiani […] sperarono sempre più ardentemente nella sconfitta, l’aiutarono, la predicarono: eppure avevano i figli in Africa, nei Balcani, in Russia. Se v’è una condizione morale tragica per il cittadino, questa lo fu. Guardare il proprio figlio come un arruolato a una bandiera straniera […]; assistere ai bombardamenti delle città dando ragione al nemico […]. Ce n’è abbastanza per comporre uno dei più tragici quadri della pazzia morale che un popolo può prendere dalle dittature».
E inevitabilmente, allora, il passo verso la guerra civile era breve. Perché, tornando agli uomini che vissero quel periodo e per fare un solo esempio, anche Dante Livio Bianco definì uno spettacolo “triste e umiliante” lo sfacelo della sua IV Armata a Cuneo, con centinaia di uomini che in disordine si precipitavano fuori dalle caserme.
Ma, scriveva Bianco: «Mai come in quel giorno abbiamo capito cos’è e cosa vuol dire l’onore militare e la dignità nazionale».
Come emerge da queste testimonianze, allora, l’8 settembre non fu la morte della Patria, ma fu la morte dell’Italia fascista, di una certa idea di Patria fascista. E l’inizio del riscatto, della guerra di liberazione e anche purtroppo, della guerra civile.
Certo: come ovvio e prevedibile, di fronte al disastro di un Paese spaccato a metà, lasciato senza guida, senza istituzioni e allo sbando, molti cercarono solo di sopravvivere alla fame, agli stenti e ai bombardamenti.
Altri, invece, aderirono allo Stato di Mussolini. È difficile comprendere le ragioni per cui molti decisero di appoggiare una Repubblica sommersa dal discredito e vista come una creatura dipendente dai tedeschi.
A parte infatti i pochi intellettuali – Giovanni Gentile, Filippo Marinetti, Arrigo Serpieri, per citarne alcuni – che ambivano a ricoprire un ruolo “nazionale”, un conto erano naturalmente i fascisti storici, i gerarchi, gli squadristi o i fanatici alla ricerca della vendetta, mossi da una fede fascista cieca. E un discorso specifico dovrebbe essere fatto per i sadici, i delinquenti e criminali di professione: si pensi solo alle bande di torturatori presenti in tutta Italia, dalla banda Koch a quelle di Gino Bardi e Guglielmo Pollastrini a Roma, fino alla banda di Mario Carità a Firenze. Una vergogna che uno Stato degno di questo nome non potrebbe tollerare.
Eppure, volgendo lo sguardo su quel disastro, ad altri non si possono oggi non riconoscere anche motivazioni di tipo ideale e patriottico. Perché a condividere quella esperienza furono anche molti giovani e giovanissimi, nati e cresciuti nel culto del Duce, imbevuti e frastornati da una insopportabile propaganda e da una retorica vuote di un qualsiasi contenuto decoroso, ma che essi non potevano capire.
Motivazioni in buona fede – per richiamare Umberto Eco – ma dettate da un malinteso amor di patria, cui si aggiungeva un altrettanto malinteso senso dell’onore perduto. E non è un caso del resto che uno dei migliori libri scritti da un reduce di Salò, Carlo Mazzantini, si intitoli «A cercar la bella morte».
Alcuni pensarono, insomma, di difendere l’onore dell’Italia infangato dal tradimento del Re, ma altri appoggiarono quel regime totalitario e razzista, voluto e mantenuto da Hitler, per convenienza ideologica e pratica.
Ed è in questo quadro allora, che dopo aver capito cosa fosse in realtà la “dignità nazionale” ricordata da Dante Bianco, arrivò anche il riscatto.
Perché proprio l’umiliazione dell’8 settembre e i mesi successivi fecero nascere in molti italiani una voglia di rivincita, la volontà di ridare dignità al popolo italiano e costruire un paese migliore. Leo Valiani, un protagonista di quella stagione, la riassunse così: «Malgrado le enormi distruzioni, non assistiamo alla fine del nostro Paese, ma alla sua rinascita rivoluzionaria». La rinascita di un popolo, scriveva ancora in un passo assai intenso, «che non si rassegna ad essere espulso dalla storia».
Quel giorno infatti nasceva la Resistenza: mentre i primi partigiani raggiungevano le montagne per iniziare a combattere – e tra questi anche Primo Levi, catturato il 13 dicembre – già il 9 settembre in via Adda, a Roma, si costituiva il Comitato di Liberazione Nazionale: «Nel momento in cui il nazismo tenta di restaurare in Roma e in Italia il suo alleato fascista – è il primo comunicato – i partiti antifascisti si costituiscono in Cln per chiamare gli italiani alla lotta e alla resistenza e per [far] riconquistare all’Italia il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni».
Le libere nazioni: eccole allora le tante motivazioni alla base della Resistenza. Certo non mancava chi voleva vendicare un congiunto caduto; o la volontà di ribellarsi ai soprusi che portava a rispondere con pari violenza alla violenza del nazifascismo.
Ma profonde erano anche le ragioni ideali: un patriottismo che si traduceva nella volontà di non cedere al dissolvimento della nazione e salvare il Paese dal crollo totale; l’obbligo morale di liberare l’Italia invasa dai tedeschi; l’impegno dei militari, di restare fedeli al giuramento di fedeltà. E poi, le convinzioni politiche: e certo, a fianco di chi voleva costruire un paese sull’esempio delle democrazie occidentali, vi era anche chi – una minoranza, grossa, ma una minoranza – sperava in una futura trasformazione socialcomunista.
Ora. È necessario evidenziare subito che non fu una stagione facile, non senza contrasti anche all’interno dello stesso pianeta antifascista.
La Resistenza non fu una festa paesana, ma una realtà dura e drammatica, che conobbe anche debolezze ed episodi tragici – si pensi a Porzûs – e scelte magari non da tutti condivise. Si pensi a via Rasella: un atto di guerra legittimo, riconosciuto dai tribunali e difeso anche da Sandro Pertini, perché «Il nemico doveva essere colpito dovunque si trovava». Ma certo episodi e scelte drammatiche e laceranti, come del resto non poteva non essere in una vicenda umana di quella gravità. Ma riconoscerli non significa in alcun modo sminuire il giudizio sul valore fondante della Resistenza della nuova Italia democratica.
Perché a prescindere dalle loro convinzioni politiche, tutti, in nome della libertà, si ribellarono contro un potere considerato illegittimo e illegale, in Italia e in Europa.
Qui si deve rintracciare – io credo – il profondo significato di quello che accadde: cosa fu la Resistenza? Fu Resistenza alla sopraffazione, intesa come un diritto e come un dovere quando la decisione da prendere non era tra la pace e la guerra, ma tra la resa e la lotta. La Resistenza e l’insurrezione considerate come un diritto e come un dovere, nell’esercizio della legittima difesa da regimi totalitari, tirannici, iniqui e illegali perché fondati sull’arbitrio, sull’abuso, sulla prevaricazione e sulla prepotenza.
Sui numeri si discute da oltre mezzo secolo. E se la zona grigia, coloro che non si schierarono, ci fu, come è naturale in frangenti a tal punto drammatici, come si può al contempo pensare a una fenomeno così importante, destinato a crescere e durare 20 mesi, senza il supporto ampio e attivo di una vasta area della popolazione? Nessun altro paese occidentale occupato conobbe un fenomeno di Resistenza, appunto, vasto come quello italiano: non i francesi, non i tedeschi, non i belgi o gli olandesi. Ma la resistenza non fu solo dei combattenti, che da poche migliaia si gonfiarono fino almeno a 250.000 persone alla vigilia dell’insurrezione.
Il carattere “nazionale” della Resistenza infatti non è dato dal numero, ma dal fatto che l’esercito ribelle era una sorta di proiezione della comunità intera, poiché a combattere vi erano tutte le categorie umane e sociali che formano un popolo: uomini e donne, giovani e meno giovani, cattolici e atei, operai e contadini, aristocratici e professionisti, studenti e professori, sacerdoti e industriali. Vi erano repubblicani ma anche monarchici. E nel Cln ebbero pari dignità liberali, democristiani, socialisti, azionisti e comunisti. Tutti uniti nel combattere i tedeschi e i fascisti, ma liberi di dare significati diversi al loro antifascismo sia in sede politica sia, successivamente, storiografica.
E, ancora, il carattere nazionale non può essere ridotto a questi soli aspetti. Perché mentre le bande iniziavano a operare e a Cefalonia si combatteva, nei lager nazisti almeno 615.000 militari deportati rifiutavano di aderire all’Asse e, a dir poco, subivano un trattamento disumano. E si pensi ancora alle staffette partigiane, e soprattutto alla “Resistenza civile”, fatta di tanti comportamenti anche spiccioli, anche episodici, che però rivelavano la solidarietà con i partigiani, con i militari, con gli ebrei.
Quei venti mesi successivi furono terribili. Furono combattute tre guerre: la guerra civile, quella di liberazione e per alcuni quella rivoluzionaria. La storiografia ha ormai da almeno trent’anni anni approfondito la complessità della vicenda, ma forse – a ben pensarci – è tutto più semplice: in fondo si confrontarono due idee diverse della Patria, due idee diverse del futuro del nostro popolo, tra chi sapeva di dover ricostruire tutto, e chi seguitava considerare come patria quella autoritaria del fascismo.
Violenze, torture, uccisioni. «Le Lettere dei condannati a morte della resistenza europea», un libro struggente e coinvolgente, spiega bene cosa sia e cosa comporti la guerra. Italiani che sparavano contro italiani in mezzo ai tedeschi e agli alleati. La linea del fronte che si sposta da sud a nord tra la linea Gustav e la linea Gotica, le stragi dell’Appennino tosco-emiliano, a Marzabotto, a Sant’Anna di Stazzema e molte altre. I tedeschi che depredano e spogliano il paese e la popolazione che combatte e cerca di sopravvivere.
Il 25 aprile 1945 la guerra finì. L’Italia fu liberata dagli Alleati, è ovvio, ma il contributo dei partigiani fu tutt’altro che secondario. Nella sola seconda metà del 1944 furono compiute 6.499 azioni di guerriglia e 5.571 atti di sabotaggio, e queste sono solo quelle censite. Ma il contributo della resistenza fu tutt’altro che trascurabile perché, come scrisse, per fare un solo esempio, il capo delle forze armate tedesche Albert Kesserling nelle sue Memorie di guerra: «A partire da quell’epoca (giugno 1944) la guerra partigiana diventò per il comando tedesco un pericolo reale la cui eliminazione era un obiettivo di importanza capitale […]. La lotta contro le bande doveva venir posta tatticamente sullo stesso piano della guerra al fronte. […] Le migliori truppe dovevano venir impegnate nella lotta contro i partigiani».
Il 25 aprile la guerra finì, e l’Italia pagò un prezzo enorme: oltre ai danni materiali, 450 mila morti e un milione e 300 mila ragazzi tra i 20 e i 35 anni inchiodati campi di prigionia in mezzo mondo – dall’Uganda, all’Australia, al Texas, in Unione Sovietica – in chissà quali condizioni.
Ma l’Italia poteva finalmente ripartire.
Oggi allora, ottant’anni dopo, e soprattutto ora che il Ventesimo secolo è finito, è giunto il tempo di iniziare a discutere del nostro passato senza barriere ideologiche.
Certo non è facile, perché i nostri padri e i nostri nonni lo hanno vissuto il Ventesimo secolo, con tutte le loro passioni, i drammi e le lacerazioni. E quindi il Novecento è ancora vicino a noi e ne sentiamo emotivamente tutto il peso.
Riconciliazione non significa allora “accordarsi” su una sorta di impossibile “memoria condivisa”, perché ognuno – da qualunque parte abbia combattuto – ha il diritto di tenersi la sua memoria e quella della sua famiglia e perché, pare ovvio, non si possono “eliminare” o annacquare pezzi di storia per raggiungere una sorta di compromesso che vada bene a tutti: i fatti non cessano di esistere nemmeno se vengono ignorati, come diceva Aldous Huxley.
Tuttavia l’impossibilità di una “memoria condivisa” non esclude, appunto, la necessità di una pacificazione che, a sua volta, «esige il senso di umana pietà per tutte le vittime della guerra, da qualunque parte abbiano combattuto», come sostenne, tra i molti, Norberto Bobbio. Un senso di umana pietà che va ben al di là del perdono, fondamento appunto di una “memoria collettiva” e a una pacificazione.
E pacificazione significa anche comprendere cosa sia successo in quella primavera del 1945, a guerra appena terminata: come ha scritto Sergio Luzzatto, la guerra civile italiana era stata lunga e feroce e non ci si poteva illudere che si chiudesse in modo indolore.
A parte gli episodi criminali, che come tali devono essere giudicati, la caccia all’uomo delle settimane successive, per vendette personali e contro criminali di guerra piccoli o grandi e che portò ad alcune migliaia di morti, significava anche voler chiedere il conto degli orrori della Repubblica Sociale Italiana e chiedere il conto di vent’anni del regime di Benito Mussolini. Un regime basato sull’oppressione politica, civile e culturale.
E vent’anni sono tanti: sono tre generazioni intere di italiani nati, cresciuti o invecchiati in un Paese in cui le libertà erano calpestate e umiliate.
Forse, partendo da questi presupposti, si può capire – non giustificare, perché la guerra era finita, e le armi dovevano essere deposte – il sovrappiù di rabbia e di odio: per alcuni “nell’Italia della Liberazione la vendetta era tanto assaporata quanto per 25 anni era stata sospirata la giustizia”.
Ma la classe dirigente, quella stessa straordinaria classe dirigente che aveva combattuto e ora prendeva legittimamente in mano l’Italia, lo aveva capito perché, a ben vedere, il Paese in realtà fu “pacificato” appena finita la guerra: come spiegare altrimenti l’amnistia del 22 giugno 1946 di Palmiro Togliatti, che comprendeva i reati di collaborazionismo, di concorso in omicidio e addirittura la tortura?
E allora, al di là delle passioni personali, comprendendo le ragioni di tutti e la pietà per i morti – e naturalmente senza considerare indecorosi calcoli politici – è necessario ancora oggi ribadire che riconciliazione non significa poter equiparare le due parti in conflitto e le loro scelte. Anzi.
Nulla può, contro l’andamento della Storia, il fervore tribunalizio di certi revisionismi o di certe agiografie. E nulla può, uguale e contrario, un certo buonismo storiografico, che mette tutto sullo stesso piano, che rinuncia a distinguere tra vincitori e vinti, che rinuncia a spiegare il senso delle alternative in lotta. Anzi, l’incapacità di dare a ciascuno il suo favorisce un’identità melliflua, e priva la democrazia delle sue categorie di giudizio e della sua stessa ragion d’essere.
Perché, come accennato, la libertà e la democrazia si sono affermate nel corso del secolo scorso attraverso lotte durissime, come quella combattuta della Resistenza. E di esse, della libertà e della democrazia, godono anche gli antichi nemici, non per una gentile concessione, ma per il sanguinoso uso della forza e al prezzo di milioni di morti. Tale è l’andamento della storia, e non è edulcorabile.
La Storia, allora, non deve giudicare la moralità dei singoli. La Storia deve giudicare i fatti e il progetto per cui si combatteva: non fu la stessa cosa combattere e morire per una causa o per l’altra, soprattutto quando alla base delle due cause vi erano approdi irrinunciabili e assoluti.
Cosa sarebbe successo, infatti, se avesse trionfato il “Nuovo Ordine Europeo” annunciato da Hitler con grande enfasi propagandistica nel luglio del 1940 e di cui tutti erano a conoscenza? Un’Italia, un’Europa e un nuovo mondo gerarchico e totalitario, con il suo fondamento di razzismo, con un espansionismo fatto di genocidi, teso a sottomettere in schiavitù intere popolazioni e ad eliminare la libertà e l’uguaglianza.
Quella libertà e uguaglianza che nazismo e fascismo rifiutavano per principio ideologico. Quella libertà e uguaglianza che nazismo e fascismo consideravano come le degenerazioni del mondo moderno prodotte dalla Rivoluzione francese.
E nondimeno, naturalmente e come sempre, di fianco alla storia di un bene vi sono anche sfumature, ombre ed errori, che nessuno minimizza o tace, come peraltro la storiografia ha sottolineato negli ultimi decenni.
Ma dopo ottant’anni, ormai, i confini della guerra civile italiana dovrebbero essere nitidi per chiunque, e non dovrebbero essere possibili malintesi sulle ragioni reali dei campi in lotta.
L’andamento della Storia non è edulcorabile: dalla Resistenza emerse una nuova classe dirigente capace di costruire un’Italia libera e democratica e scrivere una Costituzione della quale beneficiarono anche gli sconfitti, coloro che avevano difeso la dittatura. E in Assemblea Costituente, a redigere quel testo, sedevano tutti insieme con pari dignità: democristiani, azionisti, liberali, comunisti, socialisti, repubblicani, monarchici e qualunquisti. E poco dopo, in Parlamento, sedettero anche coloro che si definivano eredi del fascismo.
Proprio in quel Parlamento in cui nel 1987 sedevano su banchi contrapposti Vittorio Foa, uno dei fondatori del Partito d’Azione, condannato a 15 anni di reclusione e poi partigiano, e Giorgio Pisanò, ex repubblichino combattente della X Mas e delle Brigate Nere. E – lo ha raccontato Foa anni dopo – un giorno i due si incontrarono e Pisanò disse: «Caro Foa, dopo tanti anni di battaglie su fronti opposti, ci troviamo qui in Senato, a servire lo Stato pur con le nostre diverse idee. Possiamo stringerci la mano?». Foa rispose: «Certo, possiamo stringercela. L’importante è ricordarci che lei è qui, in Parlamento, grazie alla Costituzione; e la Costituzione c’è perché abbiamo vinto noi. Ecco quale è la differenza tra noi e voi: quando avete vinto voi io ho fatto la mia gioventù in galera. Se aveste vinto voi, io sarei rimasto in galera e lì sarei morto, adesso che abbiamo vinto noi tu sei senatore della Repubblica».
E basta questo per capire cosa fu la Resistenza e perché questi giorni appartengono a tutti: perché anche chi critica il 25 aprile – più o meno strumentalmente, e senza entrare nel merito di disonorevoli calcoli elettorali – in realtà esercita, rivendica e applica quel diritto di parola e quel diritto al dissenso che gli sono garantiti proprio perché ha vinto la Resistenza e ha costruito la democrazia.
Per questo non fu la stessa cosa combattere e morire per una causa o per l’altra, perché poi tutto si potrebbe ridurre a una domanda: cosa sarebbe successo se avessero vinto gli altri? La risposta è semplice, e il giudizio della Storia inequivocabile: vinsero i giusti, tutti insieme, e costruirono l’Italia della democrazia e della pace.
Ora. Massimo D’Azeglio scrisse che «Gli italiani sono incapaci di sacrificio se non c’è una platea ad applaudirli». Aveva torto, come dimostrarono gli almeno 44 mila partigiani morti, i 600 mila militari che rifiutarono di aderire all’Asse e rimasero nei lager nazisti, i militari di Cefalonia, i 21 mila mutilati e invalidi, le 10 mila vittime delle vigliacche e ignobili stragi nazifasciste: anziani, donne e bambini. E l’elenco potrebbe essere di molto allungato.
Non c’era nessuno ad applaudirli, ma ci siamo noi, oggi, consapevoli dell’impagabile debito di ammirazione e di riconoscenza che abbiamo nei loro confronti.
E, con l’impegno di non disperdere i loro valori e la libertà che hanno costruito per noi, possiamo solo ringraziarli e soprattutto ricordarli. Perché, come sosteneva due secoli fa Ugo Foscolo, nel ricordo si sopravvive.